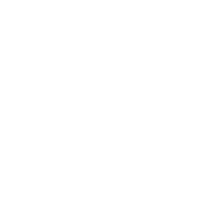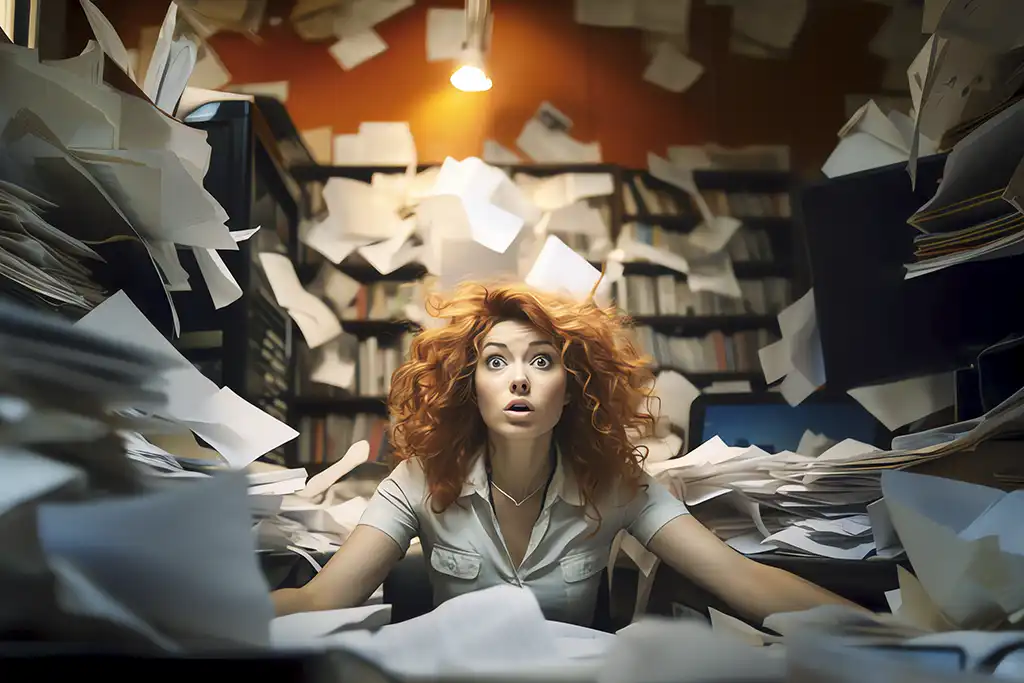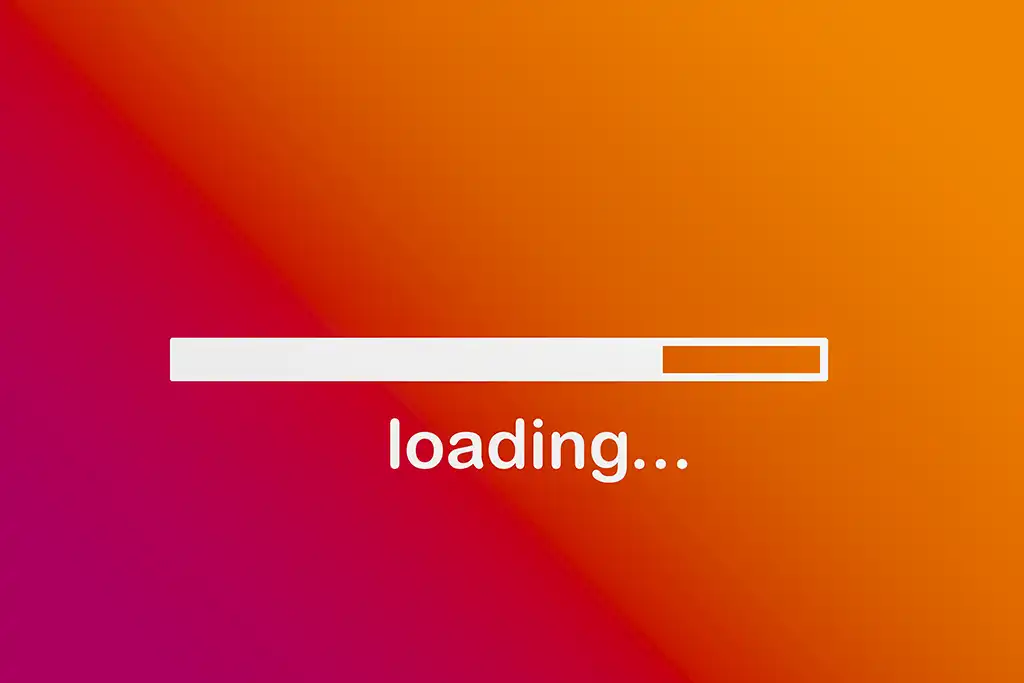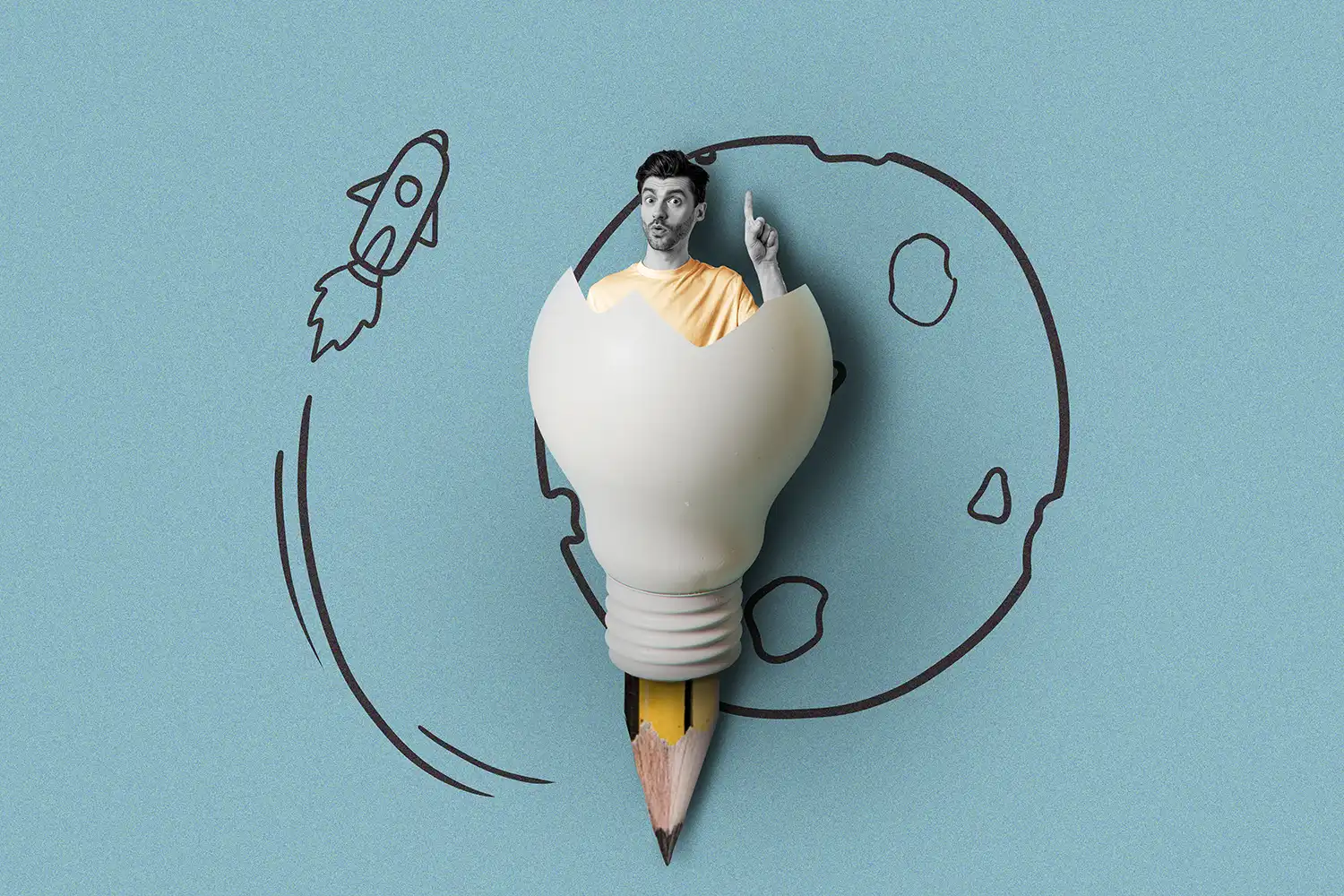Quanto può essere pericoloso un gioco di parole? Per un brand di moda globale come American Eagle, la risposta potrebbe essere: moltissimo. O forse, quel pericolo era esattamente il rischio calcolato che erano disposti a correre.
La campagna “Great Genes” con l’attrice Sydney Sweeney è un caso di studio perfetto sulle ambiguità della comunicazione contemporanea. È un terreno minato dove un messaggio apparentemente innocuo può deflagrare, rivelando le faglie culturali che attraversano la società. E dove l’intenzione di chi comunica, ammesso che fosse buona, rischia di contare meno di zero di fronte all’impatto che genera.
Analizziamo la vicenda, non per il gossip, ma per le lezioni strategiche che contiene.
Anatomia di una campagna sotto accusa
Riavvolgiamo il nastro e mettiamo a fuoco i dettagli. American Eagle, un colosso del casualwear, lancia una nuova campagna per la sua linea di jeans. La testimonial è Sydney Sweeney, una scelta strategica: non è solo un’attrice di enorme successo, ma incarna un’estetica molto precisa, mainstream, che unisce la “ragazza della porta accanto” a un ideale di bellezza classico e ampiamente condiviso.
Il claim, costruito su un evidente gioco di parole, è: “Sydney Sweeney Has Great Genes”.
L’effetto è immediato. Mentre una parte del pubblico sorride al gioco di parole, un’altra, molto più critica, reagisce con sdegno. L’accusa è grave: quella di utilizzare un “dog whistle”, un fischietto per cani. In comunicazione, un “dog whistle” è un messaggio che ha un significato palese per la maggioranza, ma anche un secondo significato, più specifico e spesso problematico, comprensibile solo a una determinata sotto-cultura.
In questo caso, l’espressione “great genes” (grandi geni), abbinata a una testimonial che rappresenta lo standard di bellezza caucasico, è stata letta come un richiamo diretto all’eugenetica. Ha evocato una retorica storica che lega la “buona genetica” a ideali di purezza razziale e superiorità, un’eco sinistra che ha trasformato un banale slogan commerciale in un potenziale manifesto politico.
Ipotesi A: L’errore madornale e l’intelligenza culturale assente
La prima interpretazione, la più generosa, è che l’intera operazione sia stata un clamoroso autogol, un prodotto della più totale inconsapevolezza.
In questo scenario, il team creativo e marketing di American Eagle viveva in una “bolla di privilegio”. Un gruppo probabilmente omogeneo per estrazione culturale e sociale, incapace di vedere il mondo con occhi diversi dai propri. Avrebbero concepito un gioco di parole che, ai loro occhi, era semplicemente simpatico e innocente, senza minimamente considerare le sue possibili e pericolose connotazioni.
Questo non è solo un errore, è un sintomo di un problema organizzativo più profondo:
- Mancanza di diversità. Un team privo di prospettive diverse non ha gli anticorpi per individuare messaggi potenzialmente dannosi.
- Assenza di “stress test” culturale. Dimostra che, con ogni probabilità, non esiste un processo interno per “mettere alla prova” le campagne, chiedendosi: “Qual è il modo peggiore in cui questo messaggio potrebbe essere interpretato? Quali gruppi potrebbe offendere?”.
Se questa è la verità, si tratta di un fallimento di intelligenza culturale che espone una debolezza strutturale. È l’ipotesi dell’incompetenza colpevole.
Ipotesi B: Il “Dog Whistle Marketing” e il profitto dalla provocazione
La seconda ipotesi è decisamente più cinica, ma strategicamente più complessa. E se l’ambiguità fosse stata l’obiettivo fin dall’inizio?
In questo scenario, American Eagle avrebbe messo in atto una precisa e calcolata strategia di dog whistle marketing. Una tattica che non mira a piacere a tutti, ma a ottenere risultati specifici attraverso la polarizzazione. Il meccanismo è diabolico nella sua semplicità:
- Creare un messaggio ambiguo. Lo slogan è studiato per avere una “plausible deniability”, una negabilità plausibile. Di fronte alle critiche, la difesa è pronta: “È solo un gioco di parole, state esagerando”.
- Scatenare la polemica. L’ambiguità stessa scatena il dibattito. Chi si sente offeso attacca, chi si sente attaccato difende il “diritto a scherzare”. Il risultato è una tempesta mediatica.
- Monetizzare l’attenzione. La controversia genera una copertura stampa e social che vale milioni, portando il brand al centro della conversazione.
- Rafforzare una base specifica. Allo stesso tempo, il messaggio “in codice” arriva forte e chiaro a quella parte di pubblico conservatore, infastidita dal politicamente corretto, che vede nel brand un alleato coraggioso che non si piega alla “cancel culture”.
È una scommessa ad alto rischio, dove si baratta la reputazione presso un pubblico progressista per la visibilità totale e la lealtà di una base più reazionaria.
La lezione per ogni brand: la responsabilità delle parole
Indipendentemente da quale fosse l’intenzione di American Eagle, le conseguenze offrono lezioni universali per chiunque si occupi di brand e comunicazione.
- L’impatto batte l’intenzione, sempre. La difesa “non volevo dire quello” è il chiodo sulla bara della credibilità di un brand. La responsabilità non sta nel giustificarsi dopo, ma nell’anticipare sempre. È necessario un processo di “red teaming” culturale: un team dedicato a smontare una campagna e a trovarne tutte le possibili falle interpretative.
- I valori di facciata non reggono. Dichiarare sui propri canali di essere un brand “inclusivo”, per poi lanciare campagne che vengono percepite come l’opposto, crea una dissonanza cognitiva che distrugge la fiducia. L’integrità di un brand non si misura dalle parole che usa nel bilancio di sostenibilità, ma dalle scelte che compie sotto pressione.
- Il danno reputazionale è un costo a lungo termine. Mentre il titolo in borsa può anche beneficiare di un picco di attenzione (le azioni di American Eagle sono effettivamente salite), il danno alla percezione del brand è più subdolo. Si rischia di alienare non solo i clienti, ma anche talenti (fotografi, designer, creativi) che non vorranno più associare il proprio nome a un marchio percepito come problematico.
Alla fine, la vicenda ci lascia con una verità ineludibile: nell’arena della comunicazione moderna, nessuna parola è innocente e nessun messaggio è neutrale. I brand vengono giudicati non solo per ciò che dicono, ma per le conversazioni che scelgono di alimentare e per i silenzi che decidono di mantenere.
La vera domanda, quindi, non è tanto “cosa ha fatto davvero American Eagle?”. La domanda che devi porti, guardando al tuo brand, è più profonda: “Siamo un’organizzazione che ha la maturità culturale per comunicare oggi? E, soprattutto, che tipo di brand vogliamo essere: uno che unisce o uno che, per profitto, divide?”.