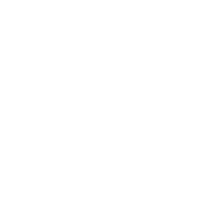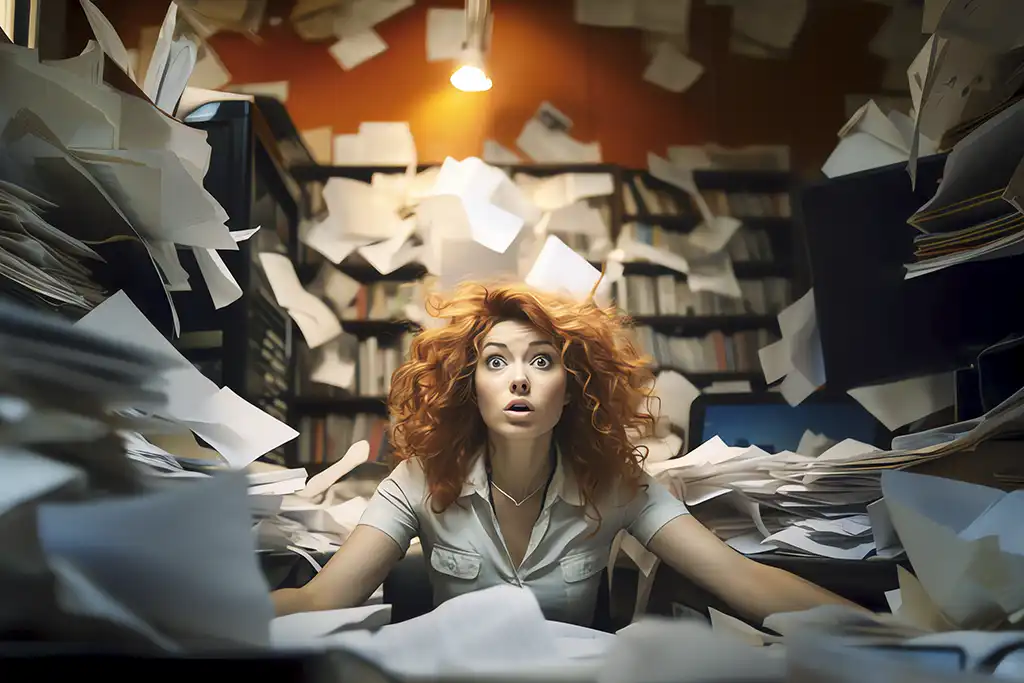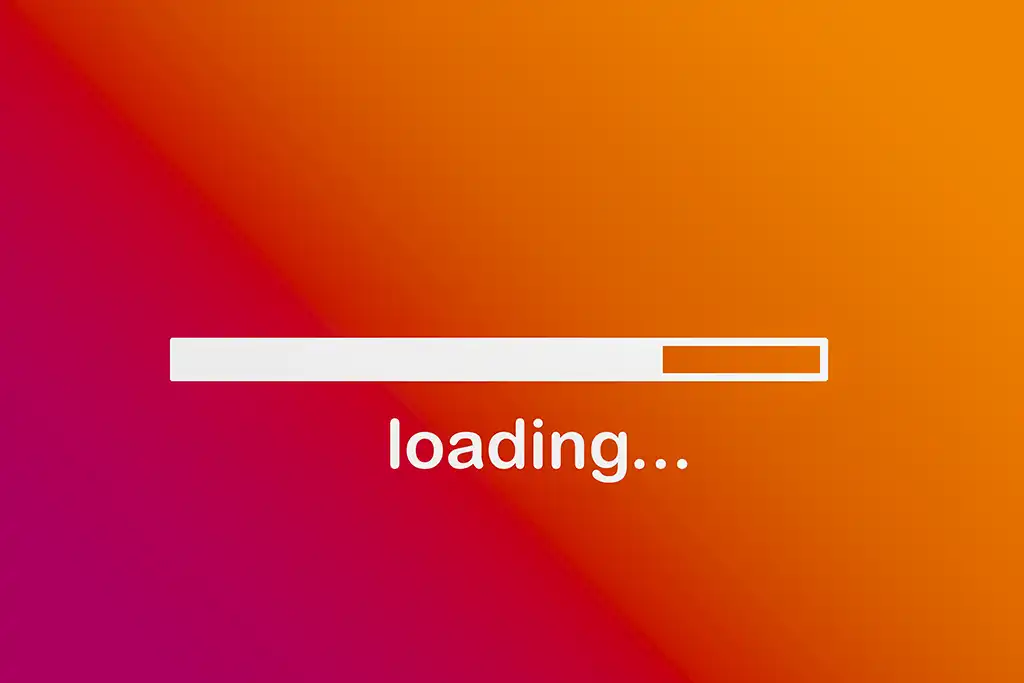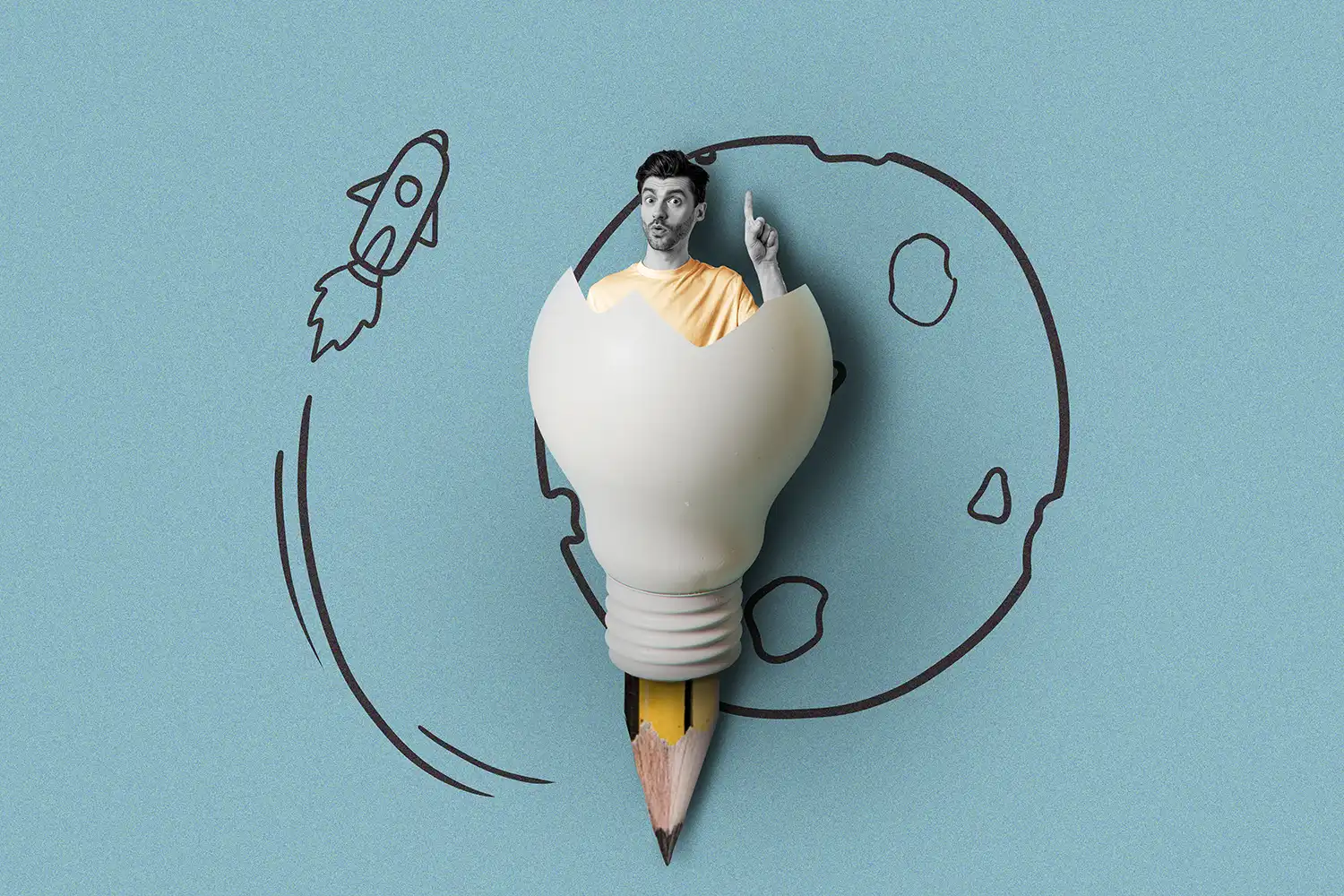Al giorno d’oggi, essere un brand non significa più semplicemente vendere un prodotto. Significa prendere una posizione. I consumatori, sempre più consapevoli e critici, chiedono alle aziende di essere attori sociali, di dimostrare un impegno tangibile su questioni come la sostenibilità ambientale, l’inclusione e, soprattutto, l’etica della produzione. In questo scenario, Coop si è da tempo ritagliata un ruolo da protagonista, costruendo parte della sua identità sulla difesa dei diritti, sulla trasparenza della filiera e sulla lotta a pratiche odiose come il caporalato.
Un posizionamento nobile e necessario. Ed è proprio partendo da questa premessa che la sua ultima campagna sulla “Passata La Densa” lascia sconcertati. Nata con l’intenzione dichiarata di promuovere un prodotto “libero dal caporalato”, l’iniziativa si rivela un incredibile catalogo di errori comunicativi. Un’operazione che, anziché rafforzare i valori del brand, li mette in discussione, dimostrando come l’esecuzione di un messaggio sia importante tanto quanto l’intenzione che lo muove. Analizzando questa campagna pezzo per pezzo, emerge un quadro di contraddizioni così evidenti da trasformare un potenziale manifesto etico in un caso di studio su ciò che non si deve fare.
Il primo inciampo: l’immagine che semplifica e ferisce
Il primo impatto con la pubblicità è visivo. Un uomo di colore, sorridente, si erge fiero in un campo di pomodori baciato dal sole, tenendo in mano un bollino con un prezzo. Sullo sfondo, altri lavoratori sono intenti alla raccolta. L’immagine è pulita, quasi idilliaca (non come lo spot de La Stampa). E proprio qui risiede il primo, enorme, problema: la scelta di un pigro stereotipo razziale per rappresentare un dramma complesso.
Il caporalato in Italia è una piaga multi-etnica. Coinvolge braccianti africani, certo, ma anche migliaia di italiani, cittadini dell’Est Europa e di altre nazionalità che vivono in condizioni di sfruttamento disumano. Ridurre questa realtà a un’icona singola e razzializzata non è solo una semplificazione giornalistica; è un atto comunicativo che deforma la realtà e rafforza un cliché dannoso. Invece di sfidare il preconcetto, la campagna vi si adagia comodamente, mancando l’opportunità di educare il pubblico sulla reale portata del fenomeno.
A questo si aggiunge il forte sospetto che l’immagine sia generata da un’intelligenza artificiale. Se così fosse, il problema sarebbe ancora più sintomatico. Le IA, addestrate su sterminati archivi di dati esistenti, tendono a riprodurre e amplificare i bias e gli stereotipi più comuni presenti nella nostra cultura visiva. Un’IA a cui si chieda di rappresentare un “lavoratore nei campi di pomodori in Italia” potrebbe facilmente restituire questa immagine, perché attinge a un immaginario collettivo già viziato. Il punto, però, è che dietro l’IA dovrebbe esserci una sensibilità umana, una direzione strategica e critica capace di correggere la macchina, di chiederle uno sforzo di rappresentazione più fedele e meno stereotipata. Se questa guida manca, il risultato è un’immagine tecnicamente perfetta ma culturalmente e socialmente povera, se non dannosa.
Il secondo errore: il design che confonde e sabota
Superato il primo livello dell’immagine, l’occhio si sposta sull’elemento grafico dominante: un grande “scoppio” rosso, una sorta di medaglia al centro della pagina in mano al bracciante. Al suo interno, campeggia una scritta enorme: “€ 0,89”. Le altre informazioni, inclusa la descrizione del prodotto, sono relegate a un corpo tipografico minuscolo, quasi illeggibile.
Questa scelta di gerarchia visiva è un disastro comunicativo. In una campagna che dovrebbe celebrare la dignità del lavoro e la lotta allo sfruttamento, il protagonista assoluto, l’eroe della narrazione, diventa il prezzo stracciato. Il messaggio non è “compra questo prodotto perché è etico”, ma “compra questo prodotto perché costa pochissimo”. L’etica diventa una nota a margine, un dettaglio per lettori attenti.
Ma c’è di peggio. L’ambiguità creata da questa impaginazione è pericolosa. In un contesto in cui si parla di lavoro e sfruttamento, sbattere in faccia al lettore un numero così basso può generare un’interpretazione terribile e non voluta: che quella cifra irrisoria possa essere associata alla paga del lavoratore. Anche se solo una frazione del pubblico lo pensasse (l’ho pensato io, ma anche altri professionisti con cui mi sono confrontato), l’operazione sarebbe comunque un fallimento. Un brand con l’esperienza di Coop non può permettersi una tale ingenuità. L’annuncio tenta di servire due padroni – la promozione commerciale e la responsabilità sociale – ma finisce per farli scontrare, con la prima che cannibalizza e svilisce completamente la seconda.
Il colpo di grazia: il prezzo che distrugge la credibilità
Se l’immagine era un inciampo e il design un autogol, il prezzo è il colpo di grazia che fa crollare l’intera impalcatura. È qui che la contraddizione diventa insanabile. La domanda sorge spontanea e brutale: può un prodotto che si vanta di una filiera equa, senza sfruttamento, tracciata, certificata, confezionato in una bottiglia di vetro da 700g, costare davvero solo 89 centesimi al consumatore finale?
Per chiunque abbia un minimo di consapevolezza sui costi di produzione, trasformazione, logistica, packaging e distribuzione, la risposta è un “no” che risuona fortissimo. Per anni, associazioni di consumatori, giornalisti d’inchiesta e brand etici hanno lavorato per educare il pubblico, spiegando che i prezzi sospettosamente bassi su prodotti come l’olio o la passata di pomodoro sono spesso il primo e più evidente campanello d’allarme dello sfruttamento lungo la filiera.
Con questa campagna, Coop compie un’inversione logica inspiegabile: usa il principale sintomo del problema (il prezzo stracciato) come simbolo della soluzione. È un paradosso che distrugge la credibilità del messaggio per qualsiasi consumatore mediamente informato. Invece di rassicurare, quel “0,89€” insospettisce. Invece di comunicare etica, evoca proprio lo spettro di quelle pratiche che la campagna vorrebbe combattere.
La lezione da imparare: l’etica non ammette scorciatoie
Questo fallimento comunicativo offre lezioni preziose. La prima è che l’etica, per un brand, non è un’etichetta da apporre su un prodotto, ma una pratica di coerenza totale. Ogni singolo aspetto della comunicazione, dal casting di un’immagine alla dimensione di un font, fino al prezzo sullo scaffale, deve sostenere e rafforzare il messaggio. Se anche un solo elemento è in contraddizione, l’intera narrazione perde di credibilità e l’operazione si trasforma in “value-washing”.
La seconda lezione riguarda la responsabilità. Un brand non è responsabile solo per ciò che intende dire, ma per l’impatto complessivo del suo messaggio. Ignorare i possibili fraintendimenti, i cliché veicolati o le contraddizioni implicite non è una svista, ma una colpa strategica.
Infine, la vera domanda che questa campagna lascia aperta è: qual era l’alternativa? Forse, la vera campagna coraggiosa e onesta non sarebbe stata quella di tentare l’impossibile equilibrio tra etica e prezzo da discount. La vera campagna coraggiosa sarebbe stata vendere quella passata a 1,19€, o a 1,39€, e usare lo spazio della pubblicità per spiegare al consumatore, con trasparenza, il perché di quel costo. Spiegare che quei centesimi in più servono a garantire la giusta paga, la sicurezza, la dignità.
Quella sì che sarebbe stata una dichiarazione forte. Avrebbe trattato il consumatore da adulto, trasformando un acquisto in un atto di consapevolezza. Invece, si è scelta la via apparentemente più facile, quella della promozione mascherata da buona causa, dimostrando che la strada per l’inferno della comunicazione è lastricata di buone intenzioni. E di cattive esecuzioni.